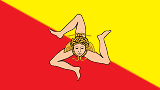Pubblichiamo una parte del capitolo della Storia d’Italia di Indro Montanelli dedicato al “brigantaggio nel Sud”. E’ la vita di Carmine Crocco, uno dei più grandi protagonisti di un periodo storico – quello degli anni successivi alla ‘presunta’ unificazione italiana – etichettato sbrigativamente come “gli anni del brigantaggio”. In realtà, più che briganti, i meridionali che si ribellavano ai Savoia, erano dei patrioti del Sud Italia che combattevano una guerra di liberazione che, purtroppo, il Mezzogiorno ha perso
Questo scritto è tratto dalla “Storia d’Italia” di Indro Montanelli, Volume VI, un libro eccezionale, come tutti i libri di storia scritti da Montanelli
“…Fra i più solleciti ci fu Carmine Crocco, un ex-pastore di Rionero in Vulture che, condannato per diserzione a vent’anni di carcere, ne era evaso, si era dato alla macchia, e in poco tempo era diventato il più temuto e rispettato capobanda della Lucania non soltanto per il suo coraggio, ma anche per la sua intelligenza di guerrigliero. All’origine della sua rivolta c’era un patetico episodio che ben illustra la condizione delle plebi meridionali. Un giorno, quando era bambino, il cane d’un signore era entrato nella sua catapecchia e aveva ammazzato un coniglio. Un suo fratello, per strapparglielo di bocca, gli assestò una bastonata che lo stese morto. Il signore se la riprese con a madre, e con tale violenza la malmenò da farla abortire e lasciarla per sempre inferma. Dopo poco il signore fu ferito da un’archibugiata. Il tribunale ne ritenne colpevole il marito della donna, e lo condannò ai lavori forzati. Solo dopo due anni e mezzo, un vecchietto del luogo che tutti ritenevano innocuo e pio, rivelò in punto di morte di esser stato lui l’autore del tentato omicidio. Carmine riebbe il padre, ma non più la madre, diventata pazza, e da allora nel suo animo non ci fu posto per altro anelito che quello della vendetta.
Disertò per non servire lo Stato che nella sua mente di analfabeta si confondeva col signore. Dopo due anni di vita alla macchia punteggiata di rapine e omicidi, si schierò con Garibaldi, partecipò all’insurrezione di Potenza, e si mise al servizio del nuovo regime, convinto di ottenere la grazia e di potervisi inserire. Invece della grazia, ebbe le manette e una nuova condanna. Ma per la seconda volta riuscì a evadere grazie all’aiuto di una famiglia di “notabili” da cui doveva uscire il più grande e illuminato studioso del Meridione: Giustino Fortunato. E riprese la sua avventurosa vita alla testa di una banda che ingrossava a vista d’occhio.
A procurargli reclute era la dissennata politica dei proconsoli piemontesi, che a Napoli avevano dato il cambio a Garibaldi, e che della situazione locale non capivano nulla, anche perché i “galantuomini” loro alleati non avevano nessun interesse a fargliela capire. Certo non si poteva improvvisare una riforma agraria che, ancorando i contadini alla terra, li sottraesse alla fame e alla tentazione del brigantaggio. Ma si potevano almeno trattenere in servizio i soldati dell’esercito borbonico che invece, dopo la battaglia del Volturno e la resa di Gaeta, furono congedati e gettati sul lastrico. Era una massa di quasi 100.000 uomini senza, un soldo né possibilità d’immediato reinserimento nella vita civile – se così possiamo chiamarla -, e quindi disponibili a qualsiasi avventura. Era fatale che si arruolassero nelle bande che già esistevano o che ne formassero di nuove. E altrettanto fatale era che da Roma, dove si era rifugiato, re Francesco tentasse di organizzarle per riconquistare il suo Reame con l’appoggio del governo papalino, sempre più ostile al processo unitario.
A Napoli, Ponza di San Martino aveva dato il cambio, come Luogotenente Generale, a Farmi. Ma né l’uno né l’altro si erano resi conto del pericolo che incombeva. Entrambi consideravano il brigantaggio come un fenomeno di delinquenza comune, reso più acuto dal disordine di quella fase di passaggio fra il vecchio e il nuovo regime, e della stessa opinione era Ricasoli a Torino. Convinti di poterlo combattere con misure di polizia, bandirono la coscrizione per rinforzare le guarnigioni piuttosto a corto di uomini perché il grosso dell’esercito era rientrato al Nord per presidiare i confini col Veneto austriaco. Ma fu un fiasco totale: dei 70 e più mila richiamati, se ne presentarono solo 20.000: il che voleva dire 50.000 disertori alla macchia. Le conseguenze si videro subito.
Abbandonando i boschi e le montagne, dove sin allora si erano tenute acquattate, le bande investirono paesi e città. Una dopo l’altra, Venosa, Ripacandida e Ginestra caddero sotto i loro colpi, e le guarnigioni vennero massacrate. Ma la cosa più grave era che, alla comparsa dei briganti, il popolino insorgeva spesso facendo piazza pulita di autorità, polizia e “galantuomini” e accoglieva le bande da “liberatrici” con luminarie, feste e Te Deum perché il clero era tutto schierato dalla loro parte. Anzi, a Pontelandolfo, furono proprio i preti che, approfittando di una processione, diedero il segnale della rivolta, e che a Casalduni guidarono la folla al linciaggio di cinquanta bersaglieri.
Così si era giunti a quel famoso raduno di Lagopesole, cui le bande si presentarono come a una specie di giuramento di Pontida per coordinare la loro azione, come mai sin allora era avvenuto, ed eleggere il capo. C’erano tutti: Nicola Somma detto Ninco-Nanco, Luigi Alonzi detto Chiavone, Gioseffi detto Caporal Teodoro, Guerra, Caruso, Malacarne, Sacchitiello, e quel Ciucciarello, di cui le donne di Andria, sua patria, seguitano a cantare un “lamento”, dove si dice che, dopo morto ammazzato, risorse come Gesù Cristo, cui a quanto pare vagamente somigliava.
Erano tutti uomini che si erano guadagnati i galloni di capibanda con prove di coraggio, di astuzia e di ferocia, non accettavano di sottomettersi a nessuno, e per questo non erano mai riusciti a mettersi d’accordo fra loro. A indurveli erano stati gli agenti borbonici, che recavano le promesse del Re, le benedizioni del Papa e gl’incoraggiamenti del comando francese, rappresentato da uno strano e misterioso avventuriero brétone, Langlois, di cui non si è mai riusciti a ricostruire i precedenti e la figura. Fu in questo arengo che Crocco venne riconosciuto Generalissimo non solo per l’autorità che gli conferivano le sue gesta, ma anche perché, sebbene mezzo analfabeta, possedeva un’oratoria immaginosa e apocalittica. “Non si commuove ancora il cielo, non freme la terra, non straripa il mare al cospetto delle infamie commesse ogni giorno dall’iniquo usurpatore piemontese?” Tutti giurarono nelle mani dei cappellani che infoltivano i ranghi di quelle squadracce e sulle immagini dei Santi e delle Madonne di cui erano imbottiti, perché questi scannatori, che adibivano i teschi delle loro vittime a boccali, erano devotissimi alla Madonna. Oltre alle coccarde, furono distribuiti gradi e uniformi. Ma Chiavone rifiutò quella di colonnello mandatagli da re Francesco perché i bottoni erano di rame: li voleva d’oro zecchino.
Alla grande assise parteciparono anche le donne dei capi: Arcangela Cotugno, moglie di Chirichigno, detto Coppolone; Maria Lucia, compagna di Ninco-Nanco; la bellissima Michelina De Cesare, compagna di Guerra; Rosa Giuliani, che in seguito denunziò e fece fucilare il suo Chiavone, che l’aveva ripudiata per una levatrice di Melfi. Qualche mese dopo giunse, con una dozzina di suoi compatrioti, un caperonzolo spagnolo, José Borjés, mezzo avventuriero, mezzo cavaliere dell’Ideale, che aveva militato sotto la bandiera di Don Carlos, il campione dell’assolutismo, e diceva di essere stato investito da re Francesco del comando supremo. Ma Crocco si rifiutò di mettersi ai suoi ordini. Non era uomo da prenderne da nessuno, e tanto meno da uno straniero che non conosceva il paese, ne parlava a malapena la lingua e pretendeva convertire quelle bande a un galateo cavalleresco e a una strategia di truppe regolari. Deluso dalla brutalità e indisciplina di quegli uomini, Borjés cercò scampo nello Stato pontificio. Ma a Tagliacozzo fu sorpreso da un reparto di bersaglieri e immediatamente fucilato coi suoi diciassette compagni.
Crocco non riuscì a tenere unite le bande, ma seguitò a esercitare su di esse una specie di alto patronato che gli permise di svolgere azioni da vera e propria guerra manovrata. A Ruvo del Monte accettò addirittura battaglia in campo aperto con un reggimento di fanteria e due squadroni di cavalleria, ne rintuzzò i tentativi di accerchiamento, e li costrinse a ritirarsi. I briganti festeggiarono la vittoria con un pantagruelico banchetto nel bosco di Monticchio, in cui vennero immolati mille polli e duecento pecore.
Finalmente a Torino si resero conto della gravità della situazione, e decisero di mandare a Napoli come Luogotenente Cialdini, che da buon militare non vide né poteva vedere le cause del brigantaggio; badò soltanto a reprimerlo, ma in questo compito spiegò la massima energia, e anche una notevole intelligenza. Rovesciando l’alleanza stabilita dai suoi predecessori col vecchio e infido elemento borbonico, attrasse dalla parte del governo quello democratico e garibaldino, che aveva per lo meno una certa esperienza di lotta contro il brigantaggio sanfedista, e col suo aiuto costituì una Guardia Mobile che, formata di gente del posto, si rivelò particolarmente efficace.
Da quel momento cominciò una terribile guerra rusticana senza esclusione di colpi né da una parte né dall’altra. Alle atrocità dei banditi, le truppe regolari risposero con fucilazioni in massa, distruzioni d’interi paesi e incendi di foreste: gran parte della desolazione del Sud coi suoi disalberati calanchi è il frutto della caccia all’uomo che imperversò in quegli anni dissennati. Quando Ricasoli, indignato, cercò d’imporre misure più umane e il rispetto della legalità, Cialdini diede le dimissioni, e Ricasoli dovette rifiutarle. Da quel momento il Generale trattò il Sud come una colonia in rivolta.
Intorno al confine con lo Stato pontificio, da cui sapeva che venivano armi, ordini e denaro, stese una vera e propria cintura. E trattò il clero, ch’era il vero sobillatore della guerriglia, con pugno di ferro, senza riguardo nemmeno per i più alti porporati. Oltre al Cardinale di Napoli, Rialzo Sforza, furono ben settanta i Vescovi espulsi, fuggiti, o arrestati per collusione coi briganti. Tuttavia, per portare avanti le operazioni, gli ci vollero 120.000 uomini, per molti dei quali quella tremenda repressione rappresentò un’atroce sorpresa e un drammatico caso di coscienza.
“Io sono ributtato da questa guerra atroce e bassa – scriveva Gaetano Negri, futuro sindaco di Milano -, dove non si procede che per tradimenti e per intrighi, dove spogliamo il carattere di soldati per assumere quello di sbirri, e sospiro all’istante di abbandonare questa atmosfera di delitti e di bassezze”.
Gli uomini di Cialdini infatti non combattevano soltanto con le armi, ma anche con la corruzione e i patteggiamenti sotto banco per dividere le bande e isolarne i capi. Crocco si rivelò guerrigliero di grandi risorse anche nel parare questi colpi e nel restituirli adeguatamente. Uno dopo l’altro, egli individuò tutti gli’informatori dell’esercito che militavano nelle sue fila; ma invece di ucciderli se ne servi per fargli dare notizie false. L’unico che riuscì a batterlo fu quel colonnello Pallavicini che, dopo essersi malamente guadagnato i gradi di Generale con la cattura di Garibaldi ad Aspromonte, dimostrò tuttavia di meritarseli non solo per la decisione ma anche per l’abilità con cui condusse la caccia all’irriducibile bandito. Egli non esitò ad accordarsi con Caruso [Giuseppe], ch’era caduto vivo nelle sue mani e che odiava Crocco, lo trasse dal carcere, e ne fece il proprio consulente, nonostante le efferatezze di cui si era macchiato.
Caruso gli rivelò il nome degl’informatori e manutengoli di Crocco, e gl’insegnò i rifugi che gli servivano di base nei boschi di Monticchio e di Lagopesole. Seguendo questi fili, la caccia all’indomito guerrigliero si fece così serrata e pressante che questi nel ’64 sbandò i suoi uomini e si rifugiò nello Stato pontificio. Era sicuro di essere accolto come un eroe da re Francesco che, insieme al grado di Generale, gli aveva mandato tanti affettuosi messaggi. Lo accolse invece la polizia, che lo gettò in prigione e nel 70 lo consegnò alle autorità italiane, che lo condannarono all’ergastolo. Qui Crocco si trasformò da uomo di spada in uomo di penna e scrisse un libro di memorie, viziato dall’enfasi e dalle reticenze, ma non privo di spunti descrittivamente efficaci sulla vita dei briganti, e abbastanza sincero.
Robusto com’era e rotto a tutto, resse bene alle privazioni del carcere, e morì vecchio. Il capitano Massa, che lo vide dopo vent’anni di lavori forzati, scrisse:
“Ha gli occhi castagni, i capelli leggermente brizzolati, il naso greco, la bocca, il mento, il viso regolari, la fronte ampia, solcata da poche rughe. Calmo, sereno, ilare, ubbidiente e docile con tutti, rispettosissimo verso le guardie carcerarie, riconoscente verso chi può fargli un po’ di bene”.
Il suo libro finiva con queste parole: “Io non ho mai potuto comprendere come sia composto il consorzio sociale. So che il disonesto nessuno lo può vedere, ma la legge non lo colpisce, e poi chiama scellerato colui che lo assassina, e non si vuole comprendere come non tutti gli uomini siano degni di vivere”.
Il suo ritiro dalla lotta aveva segnato la fine di quell’atroce guerra. Uno dopo l’altro, i capibanda caddero, quasi tutti con l’arma in pugno. Ninco-Nanco, catturato vivo, fu ucciso da uno dei suoi mentre lo trascinavano via, perché non parlasse. Neanche per le loro compagne ci fu clemenza: finirono quasi tutte fucilate ed esposte nude sulla pubblica piazza. Quanti uomini fosse costata quella guerra, non si è mai saputo con precisione. Alla commissione d’inchiesta, La Marmora dichiarò: “Dal mese di maggio del ’61 al febbraio del ’63, abbiamo ucciso o fucilato 7.151 briganti”, ma che tutti lo fossero c’è da dubitare. Le perdite dell’esercito non sono mai state accertate, ma pare che superassero quelle di tutte le campagne contro l’Austria. Era logico che l’opinione pubblica ne restasse traumatizzata, e il suo stato d’animo lo riassunse D’Azeglio in una lettera a Matteucci:
“La questione del tenere Napoli o non tenerla mi pare che dovrebbe dipendere più di tutti dai napoletani, salvo che vogliamo, per comodo di circostanze, cambiare quei principi che abbiamo sin qui proclamati. A Napoli abbiamo cacciato un Sovrano per stabilire un governo sul consenso universale. Ma ci vogliono, e pare che non bastino, 60 battaglioni per tenere il Regno, ed è notorio che, briganti o non briganti, non tutti ne vogliono sapere. Mi diranno: e il suffragio universale? Io non so niente di suffragio, ma so che di qua dal Tronto non ci vogliono 60 battaglioni, e di là sì. Dunque dev’esser corso qualche errore. Dunque, o cambiar principio o cambiar atti, e trovar modo di sapere dai napoletani una buona volta se ci vogliono, sì o no. Perché a chi volesse chiamar tedeschi in Italia, credo che gl’italiani che non li vogliono hanno diritto di fare la guerra. Ma a italiani che, rimanendo italiani, non volessero unirsi a noi, non abbiamo diritto di dare archibusate”.
QUI IL CAPITOLO DEL LIBRO (VI VOLUME DELLA STORIA D’ITALIA) DI INDRO MONTANELLI PER ESTESO
Foto tratta da ilsudonline.it
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.-La redazione
Effettua una donazione con paypal